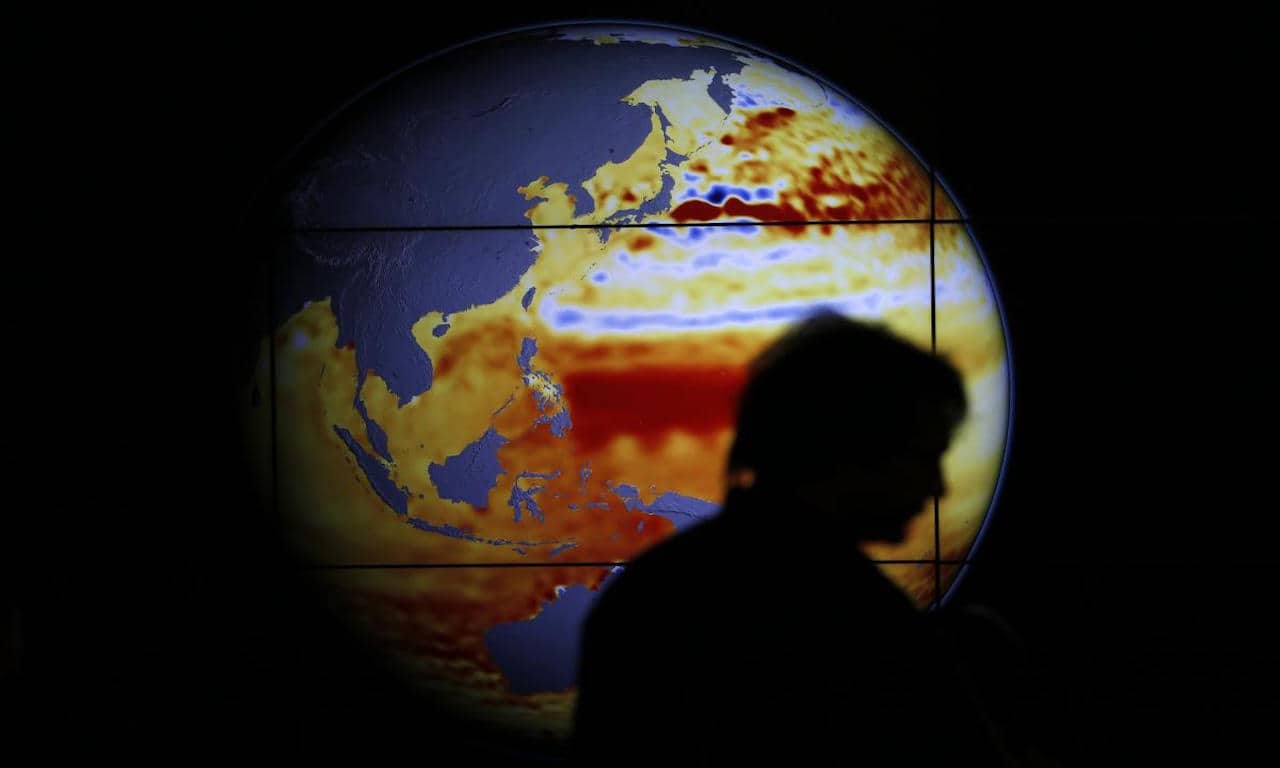Da storico e geografo, non nascondo le mie perplessità ogni volta che sento parlare di «geopolitica», materia che Sergio Romano, sulle pagine del Corriere della Sera, non ha esitato a definire «una pseudoscienza che la mitologia razziale e le credenze esoteriche di Adolf Hitler avevano trasformato in una micidiale religione del potere». Alle sulfuree radici di questa disciplina si aggiunga il fatto che ormai l’uso di questo termine ha invaso gran parte dello spazio comunicativo, a mio avviso impoverendolo: se tutto è geopolitica, nulla è geopolitica. Tra l’altro il proliferare di questo approccio non sembra aver significativamente apportato migliorie al processo decisionale, vista la disastrosa condizione in cui versa il mondo. Inoltre, come afferma l’analista Francesco Marradi, «il prefisso “geo” apposto a un termine eleva la relativa materia al rango di competizione o conflitto globale. Ovvero, qualora si tratti di materia che non riconosce confini, alla sua cattura entro il dominio nazionale per farne strumento di competizione o conflitto». Come a dire che se dalla cassetta degli attrezzi tiri fuori solo il martello non farai altro che dare martellate. Invece abbiamo bisogno di tutti gli attrezzi e di sviluppare una sensibilità e un approccio più raffinato alle dinamiche globali.
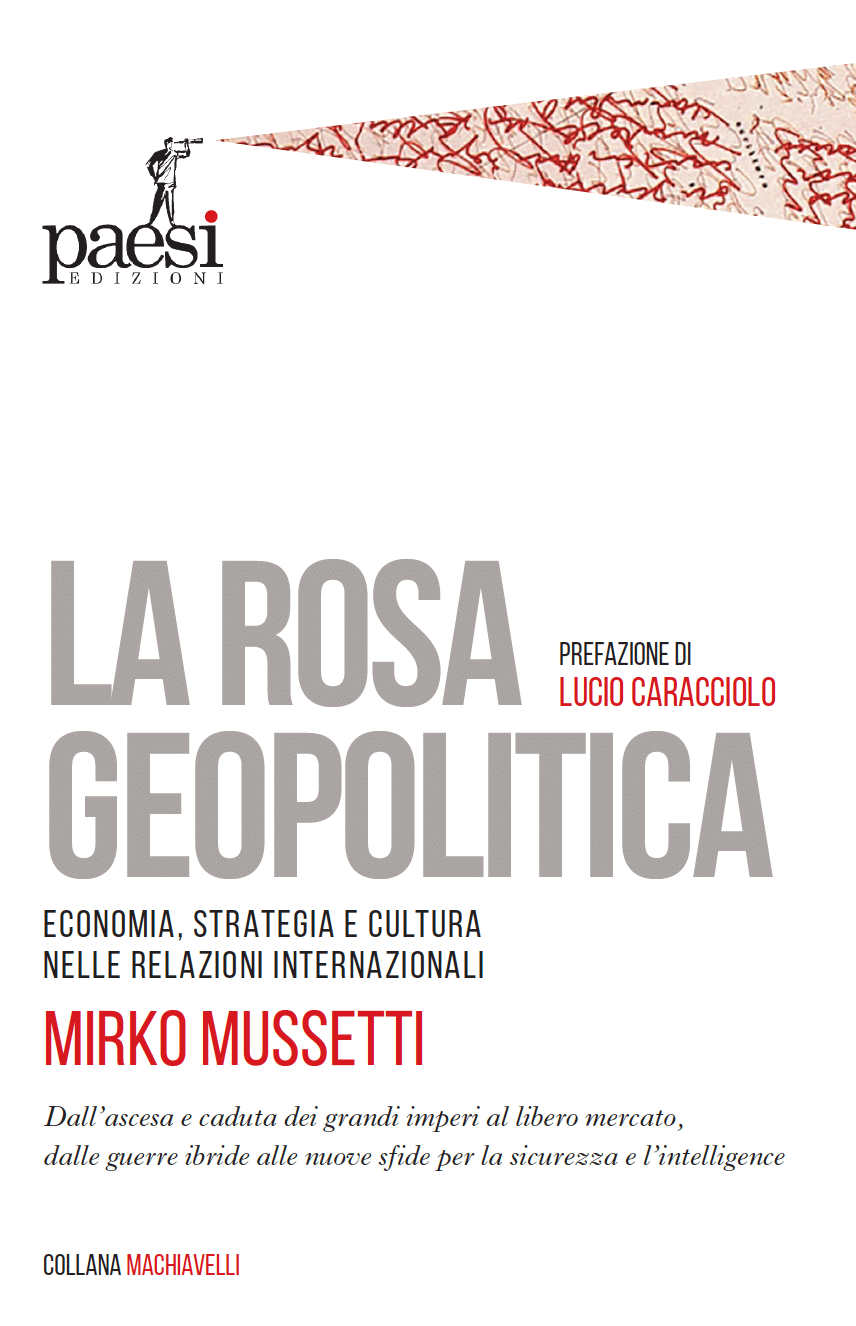 E questo è il motivo per cui, al di là della presenza del termine «geopolitica» nel titolo di questo saggio, ho accettato l’invito a scrivere questa breve nota destinata ad accompagnare le riflessioni di Mirko Mussetti, a cui tra l’altro va riconosciuto il fatto di aver posto l’attenzione – in suoi precedenti lavori – su alcune realtà geografiche scarsamente considerate nel dibattito italiano (penso al Mar Nero) ma destinate a una nuova centralità per i futuri equilibri di potenza. Ritengo che queste pagine abbiano il merito di ricordarci come la sfera della «politica» sia sempre necessariamente condizionata da una conoscenza approfondita della storia, della geografia, della filosofia, della sociologia e della psicologia non solo del proprio Paese di appartenenza, ma ugualmente di ogni altra area del mondo e delle relazioni internazionali tra Stati e regioni. Mussetti prova definire un approccio in grado di inquadrare in modo sistemico tutte le competenze elencate, e dal suo punto di vista l’indispensabile competenza richiesta ai leader contemporanei nel mondo delle istituzioni ma anche delle imprese diventa la comprensione delle dinamiche geopolitiche.
E questo è il motivo per cui, al di là della presenza del termine «geopolitica» nel titolo di questo saggio, ho accettato l’invito a scrivere questa breve nota destinata ad accompagnare le riflessioni di Mirko Mussetti, a cui tra l’altro va riconosciuto il fatto di aver posto l’attenzione – in suoi precedenti lavori – su alcune realtà geografiche scarsamente considerate nel dibattito italiano (penso al Mar Nero) ma destinate a una nuova centralità per i futuri equilibri di potenza. Ritengo che queste pagine abbiano il merito di ricordarci come la sfera della «politica» sia sempre necessariamente condizionata da una conoscenza approfondita della storia, della geografia, della filosofia, della sociologia e della psicologia non solo del proprio Paese di appartenenza, ma ugualmente di ogni altra area del mondo e delle relazioni internazionali tra Stati e regioni. Mussetti prova definire un approccio in grado di inquadrare in modo sistemico tutte le competenze elencate, e dal suo punto di vista l’indispensabile competenza richiesta ai leader contemporanei nel mondo delle istituzioni ma anche delle imprese diventa la comprensione delle dinamiche geopolitiche.
Su un fatto sono assolutamente d’accordo: affinare queste «sensibilità» è oggi ancora più importante perché la crisi del mondo globale sta delineando sempre più una nuova dinamica: alto vs basso, centro vs periferie, il tutto accompagnato da «cambi di paradigma» tecnologici che accelerano il «paretiano» ricambio delle élite. Quindi politici, uomini delle istituzioni, ceo e manager, hanno bisogno di tutto ciò per «orientarsi» nel mondo plasmato dall’impetuosa crescita economica della Cina, dall’eredità dei neocon, dalle guerre in Afghanistan, in Iraq, in Libia e in Siria, dalle crescenti conflittualità di ordine religioso, dai poderosi flussi migratori, e soprattutto dal collasso delle istituzioni e delle pratiche multilaterali, dall’internazionalizzazione dei mercati e dalle tempeste finanziarie.
In realtà si tratta di un approccio che i dirigenti più accorti hanno sempre coltivato. Se riprendiamo in mano il volume Industria e potere mondiale di Giuseppe Sacco, scopriamo che già negli anni ’70 la Fiat in Brasile per favorire la propria penetrazione sul mercato produsse per qualche tempo, tra gli altri modelli, una 600 che andava ad alcol, piegandosi all’idea a quel tempo in voga in America Latina della import substitution volta a sostituire con un sottoprodotto dello zucchero il petrolio di cui il Paese allora scarseggiava. Nel nord dell’Argentina, invece, la stessa Fiat produceva i suoi modelli a benzina, a costi però molto più alti di Torino, perché tutto o quasi doveva essere produzione nazionale, sotto una protezione doganale altissima. Come ci ricorda sempre Sacco: «Tra le Fiat dei due Paesi non c’erano praticamente scambi, che si sviluppano invece dopo l’avvento della globalizzazione, quando entrambi gli impianti sono entrati in una filiera internazionale che divide tra vari Paesi la produzione delle varie componenti e delle varie operazioni produttive. Dapprima ci si piegava quindi nel quadro ispirato dalla conferenza di Bandung; a partire dagli anni ’90 invece si opera del quadro geopolitico caratterizzato dalla nascita della Wto».
È del tutto evidente come l’interconnessione economica e il numero sempre maggiore di fattori in grado di influenzare gli equilibri internazionali e i governi di molte nazioni determinino situazioni a causa delle quali ogni evento rilevante tecnologico, politico, finanziario o ambientale, abbia conseguenze pressoché globali. Questo volume raccoglie la sfida di promuovere una cultura della comprensione globale degli scenari e dei mercati, proponendo un progetto strutturato per aiutare politici e manager – italiani – a comprendere queste dinamiche e le loro implicazioni.
di Salvatore Santangelo
dalla postfazione al libro
La rosa geopolitica
di Mirko Mussetti
Redazione
La redazione di Babilon è composta da giovani giornalisti, analisti e ricercatori attenti alle dinamiche mondiali. Il nostro obiettivo è rendere più comprensibile la geopolitica a tutti i tipi di lettori.
A che punto sono i rapporti tra Italia e Cina?
1 Mar 2024
Generalmente a livello mediatico in Italia vale la teoria del riflettore. Si accende e si spegne all'uopo la luce su un…
Come decifrare l’influenza cinese in Italia
18 Dic 2023
Posto che le attività di sorveglianza in Cina sono spiccatamente funzionali alla definizione del regime politico di…
Mantici, un uomo come pochi che mancherà a tanti
27 Nov 2023
Addio Duccio, ci hai dato tanto e ancora tanto avresti avuto da dare a noi colleghi, amici, allievi e al tuo amato…
Addio ad Alfredo Mantici: «Mai indossare gli occhiali dell’ideologia»
24 Nov 2023
Il «secondo mestiere più antico del mondo». Questa è la definizione che la vulgata popolare attribuisce…