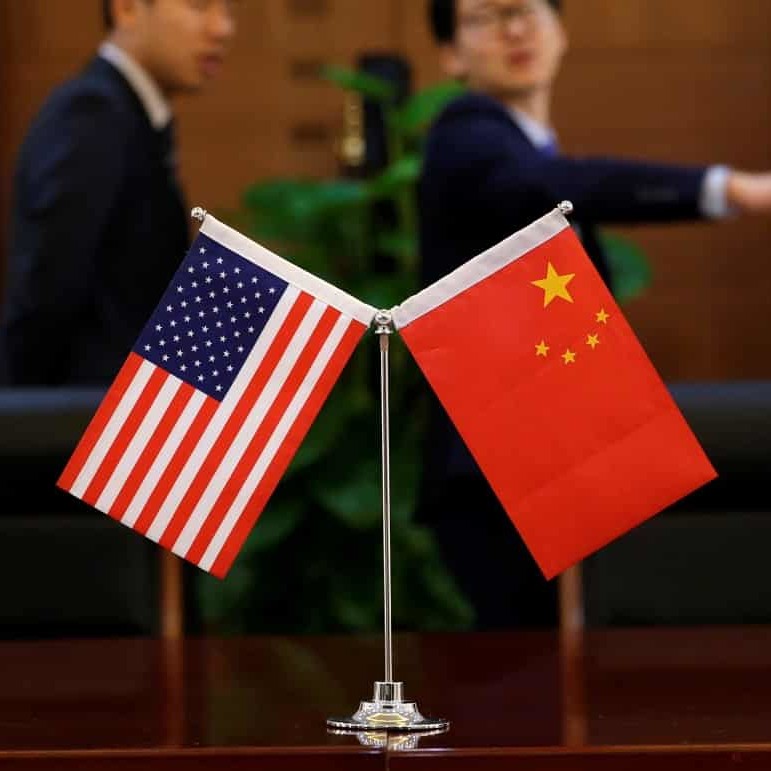L’Expo di Milano del 2015 dal titolo “Feeding the Planet, Energy for Life” ha visto il grande successo del padiglione del Giappone. Con oltre due milioni di visitatori, è stata una delle strutture più visitate meritandosi il gold prize come miglior esibizione. Il padiglione ha mostrato ai visitatori la cultura culinaria giapponese, dai suoi ingredienti tradizionali alle tecniche di produzioni finanche alle abitudini a tavola. Ma il successo della cucina giapponese era già stato preceduto da un altro grande riconoscimento internazionale: l’iscrizione del washoku (la cucina tradizionale giapponese) nel patrimonio intangibile dell’umanità da parte dell’UNESCO nel dicembre 2013. La popolarità del washoku è ulteriormente dimostrata dal numero crescente di ristoranti giapponesi in tutto il mondo. Secondo il MAFF (il Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e delle Foreste del Giappone) il numero di ristoranti che servono la tradizionale cucina nipponica sono aumentati dai 24.000 del 2006 agli oltre 117.000 del 2017. A ciò bisogna aggiungere il notevole incremento delle esportazioni agroalimentari del Giappone, passate dai 445 miliardi di yen del 2009 agli oltre 750 miliardi del 2016. Un successo ben visibile anche nelle principali città italiane dove ormai non si contano più le aperture di ristoranti giapponesi.
Tuttavia, questo successo non è frutto del caso, ma il risultato di una politica ben mirata attuata dalle autorità nipponiche, definita «gastrodiplomazia». Il termine «gastrodiplomazia» nasce nel mondo accademico ad opera dello studioso Chapple-sokol ed è impiegato per indicare non solo la semplice promozione della cucina tradizionale di un paese al di fuori dei suoi confini nazionali, ma anche – e, direi, soprattutto – l’uso da parte delle autorità del cibo come uno strumento di soft power (inteso come la capacità di uno stato di creare consenso attraverso la persuasione), atto ad incrementare il fascino e la desiderabilità della cultura, dei valori e degli ideali di un paese e a ottenere anche dei risultati economici, come l’aumento delle esportazioni. A tal fine, è necessario che la cucina di un paese passi attraverso un processo di forte standardizzazione, che è stato definito «gastronazionalismo» (De Soucey, 2010), e di ottenere un certo riconoscimento internazionale, come può essere quello da parte dell’UNESCO. Nel caso giapponese, la promozione del washoku all’estero è strettamente legato al basso indice di autosufficienza alimentare del paese. Il Giappone, infatti, soffre di una bassissima produzione agricola nazionale, dovuta a una naturale mancanza di terreni da coltivare ma anche all’invecchiamento della popolazione rurale, ai bassi guadagni del settore e al diffondersi della dieta occidentale, che ha fatto aumentare drasticamente le importazioni di prodotti agroalimentari dall’estero. Oggi, oltre il 60% del cibo consumato in Giappone viene importato. Negli ultimi venti anni, il governo ha provato più volte a invertire questa tendenza cercando di promuovere tra i giapponesi il ritorno alla dieta tradizionale, una strategia che tuttavia si è dimostrata infruttuosa. Da qui, dunque, l’idea di promuovere i cibi giapponesi all’estero, al fine di incrementare la domanda di questi prodotti e aiutare la settore agricola nazionale.
Nel 2005, all’interno della strategia per la promozione della cultura giapponese all’estero, fu creata la Commissione per la Promozione della Ricerca sulla Cultura Alimentare. La Commissione, nel suo rapporto, reiterò l’importanza del cibo quale strumento per la promozione di un’immagine positiva del Giappone all’estero e raccomandò alcune misure come la standardizzazione dell’offerta dei ristoranti giapponesi all’estero, la creazione di corsi di cucina giapponese per stranieri, la promozione della cucina tradizionali ai turisti stranieri in Giappone. Fu così che nel 2006 fu lanciata la prima campagna per la presentazione della cucina giapponese all’estero dal titolo “Washoku-Try Japan’s Good Food”. L’obiettivo della campagna era presentare i piatti tipici giapponesi all’interno di manifestazioni ed eventi speciali all’estero. Nello stesso anno il MAFF introdusse una misura particolarmente aggressiva, ovvero la creazione di un sistema di certificazioni per i ristoranti giapponesi all’estero, per monitorare l’ “autenticità” di questi ristoranti. Questa misura fu duramente criticata e da molti definita come “la polizia del sushi” e per questo nel 2007 il MAFF sostituì il sistema delle certificazioni con uno di “raccomandazioni”, trasferendo l’attività ad una organizzazione non-governitiva chiamata “Organization to Promote Japanese Restaurants Abroad”. Questa attività di promozione ha visto poi il coinvolgimento anche di altri ministeri, come quello degli Esteri e qeullo dell’Economia e del Commercio. Più recentemente, nel 2017, è stato creato anche il Japan Food Products Overseas Promotion Center, con il compito di analizzare i mercati esteri per facilitare la promozione del cibo giapponese.
È dunque evidente come oggi il cibo sia uno dei principali strumenti del soft power del Giappone. Se da un lato, il governo sottolinea l’importanza del cibo come elemento elemento dell’identità giapponese, dall’altra parte se ne serve anche per raggiungere obiettivi di natura economica, come l’aumento della produzione agricola nazionale e l’incremento delle esportazioni di prodotti agro-alimentari.
Felice Farina
assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale". Si occupa di storia contemporanea del Giappone e politica estera giapponese. Ha conseguito un dottorato di ricerca presso lo stesso ateneo con una tesi sul rapporto tra la sicurezza alimentare e la diplomazia del Giappone
La crisi della democrazia negli Stati Uniti
14 Lug 2024
Che America è quella che andrà al voto il 5 novembre 2024 per eleggere il suo presidente? Chi vincerà lo scontro tra…
Viktor Orbán, storia di un autorevole autoritario
9 Lug 2024
Era il primo gennaio 2012 quando la nuova, e subito contestata, Costituzione ungherese entrava in vigore. I segnali di…
L’Europa e le vere sfide del nostro tempo
29 Mag 2024
Nel saggio Rompere l'assedio, in uscita il 31 maggio per Paesi Edizioni, Roberto Arditti, giornalista da oltre…
Hi-Tech: i punti deboli della Cina
21 Mag 2024
La sfida tra Stati Uniti e Cina in campo tecnologico mostra una Cina nettamente indebolita nonostante la sua guerra…