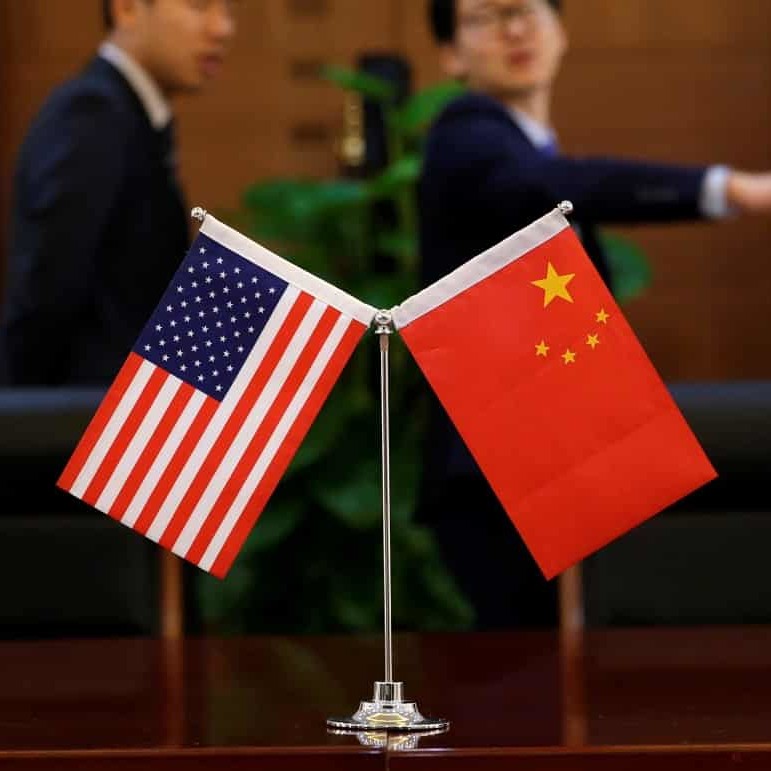Il Bangladesh ha firmato un accordo con il Myanmar per rimpatriare centinaia di migliaia di musulmani Rohingya, fuggiti dalle repressioni dell’esercito birmano. Anche se non sono stati resi noti dettagli dell’accordo tra i due governi, Dacca ha sostenuto che questo rappresenta «un primo passo importante», mentre Naypyidaw ha risposto che il suo paese è pronto a ricevere altri transfughi «il prima possibile».
Resta la preoccupazione che questo ritorno forzato dei Rohingya – una comunità musulmana in un Paese a maggioranza buddhista – non fermi le violenze contro di loro, né la pulizia etnica denunciata dagli stessi migranti non appena varcato il confine. Una denuncia accolta anche dal segretario di stato americano Rex Tillerson, il quale a metà novembre ha dichiarato che «l’azione militare del Myanmar contro la minoranza della popolazione Rohingya costituisce una pulizia etnica». Sinora, si calcola che siano oltre 600mila le persone fuggite in Bangladesh, dopo che nel corso del 2017 nello stato di Rakhine sono scoppiate nuove violenze.

La questione è annora: nel 1978, oltre 200mila Rohingya furono costretti a fuggire dall’operazione Nagamin (Re Drago), ovvero un’azione di repressione dell’esercito birmano che puntava a distruggere le moschee e a disperdere i civili di fede musulmana giustificandola come un’azione contro gli stranieri che si erano infiltrati nel Paese illegalmente. Così anche nel 1991 e 1992, quando le violazioni dei diritti umani e il lavoro forzato (e non remunerato) provocò nuovi disordini. Infine, tra il 2011 e il 2012 una rivolta popolare scoppiata per presunti stupri a opera di giovani musulmani fece circa duecento morti nello stato occidentale del Rakhine, costringendo decine di migliaia di Rohingya a lasciare nuovamente le loro case (molti morirono nel tentativo di attraversare il confine via mare).
Oggi la situazione sul terreno non è mutata: negli ultimi mesi, la violenza è riesplosa dopo che una serie di attacchi terroristici contro la polizia di frontiera hanno provocato la dura reazione dell’esercito, che ha lanciato un’offensiva militare brutale, tale da costringere decine di migliaia di Rohingya a tentare la fuga in Bangladesh. Adesso, i confini nord dello stato di Rakhine sono stati chiusi ed è vietato l’accesso anche agli operatori umanitari. Come finirà questa storia, dipenderà anche dai buoni uffici di Aung San Suu Kyi, dall’esercito birmano e dal governo di Dacca.
Chi sono i Rohingya
I Rohingya sono una minoranza musulmana apolide stanziata nello stato di Rakhine, che si estende lungo la fascia costiera del Myanmar sino al confine con il Bangladesh, in quello che un tempo era il Bengala Orientale. Oggi quest’area è additata dai militari come un “santuario di estremismo” dove si anniderebbero anche jihadisti dello Stato Islamico. Ma la cosa è tutt’altro che verificata e appare più come una scusa per giustificare il pugno di ferro dei militari allo scopo di allontanare definitivamente questo gruppo etnico dal Paese.
Spesso descritti come «il popolo meno voluto al mondo» e definiti dall’ONU «una delle minoranze più perseguitate al mondo», i Rohingya corrispondono a circa un milione e duecentomila persone, su una popolazione totale di oltre 56 milioni di birmani. Il Myanmar non li riconosce come cittadini né come uno dei 135 gruppi etnici che sono presenti nel Paese. Per tale ragione gli sono negati i diritti all’istruzione e alla proprietà, e la terra su cui vivono può essere loro tolta in qualsiasi momento. Inoltre, secondo una legge sulla concessione della cittadinanza del 1982, non possono neanche prendere la cittadinanza birmana, né fare più di due figli.

Non gli è neppure consentito di viaggiare senza un permesso ufficiale, cosicché è difficile per i Rohingya riconnettersi con i correligionari che da anni sono emigrati in Bangladesh (uno degli stati più densamente popolati al mondo). Ragion per cui oggi in quest’area sorgono sterminati campi profughi: come quello di Leda nei pressi di Teknaf, sud del Bangladesh, dove vivono in condizioni al limite dell’umano almeno 15mila degli oltre 500mila musulmani sfollati nel paese. Altri campi si trovano a Kutupalong e Nayapara. Nel settembre del 2016, l’UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) stimava in oltre 32mila le persone registrate in questi campi profughi, ma questi numeri sottostimano la “bomba demografica” dell’intera regione.
Se in Myanmar il tasso medio di povertà è al 37%, nello stato di Rakhine questa cifra sale al 78%. In quest’area, soprattutto nelle città di Maungdaw e Buthidaung, si concentra la maggior parte dei residenti Rohingya. Il resto della comunità dei musulmani del Myanmar vive nelle zone centrali e meridionali, dove si contano circa 120mila sfollati interni, registrati presso i campi governativi.
Lo status legale dei Rohingya
I Rohingya sono un popolo con una forte identità etnica, religiosa e linguistica, ma ancora senza stato. Il Myanmar li ritiene «una minaccia per la razza e la religione» e da decenni attua nei loro confronti politiche discriminatorie e azioni violente in nome della sicurezza nazionale: come detto, il governo dei militari ritiene infatti che all’interno della comunità vi siano infiltrazioni di gruppi estremisti islamici.
Le cause principali dell’esodo sono proprio lo status legale incerto e le conseguenti repressioni subite nello stato di Rakhine. A partire dalla legge del 1982, molti di loro hanno ricevuto una carta provvisoria, che ne certifica l’identità ma non la cittadinanza birmana. Di conseguenza, i controlli insistenti della polizia e la repressione militare hanno costretto molti dei Rohingya ad auto-dichiararsi Bengali, cioè originari del Bangladesh e, quindi, immigrati irregolari.
Dal giugno 2016, quest’obbligo è venuto meno su indicazione delle leader birmana Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991 e oggi consigliere di Stato della Birmania, nonché ministro degli Affari Esteri e ministro dell’Ufficio del presidente. Tuttavia, se la minoranza musulmana non è più costretta a dichiararsi Bengali, non può nemmeno definirsi Rohingya. La stessa Aung San Suu Kyi, infatti, consapevole del sentimento anti-musulmano molto diffuso nel Paese, ha chiesto ai diplomatici stranieri di non usare questo termine, preferendo l’espressione più generica di «comunità musulmana nello stato di Rakhine», condannando questo popolo a condurre una vita da apolidi, senza una vera identità.
Redazione
La redazione di Babilon è composta da giovani giornalisti, analisti e ricercatori attenti alle dinamiche mondiali. Il nostro obiettivo è rendere più comprensibile la geopolitica a tutti i tipi di lettori.
La crisi della democrazia negli Stati Uniti
14 Lug 2024
Che America è quella che andrà al voto il 5 novembre 2024 per eleggere il suo presidente? Chi vincerà lo scontro tra…
Viktor Orbán, storia di un autorevole autoritario
9 Lug 2024
Era il primo gennaio 2012 quando la nuova, e subito contestata, Costituzione ungherese entrava in vigore. I segnali di…
L’Europa e le vere sfide del nostro tempo
29 Mag 2024
Nel saggio Rompere l'assedio, in uscita il 31 maggio per Paesi Edizioni, Roberto Arditti, giornalista da oltre…
Hi-Tech: i punti deboli della Cina
21 Mag 2024
La sfida tra Stati Uniti e Cina in campo tecnologico mostra una Cina nettamente indebolita nonostante la sua guerra…