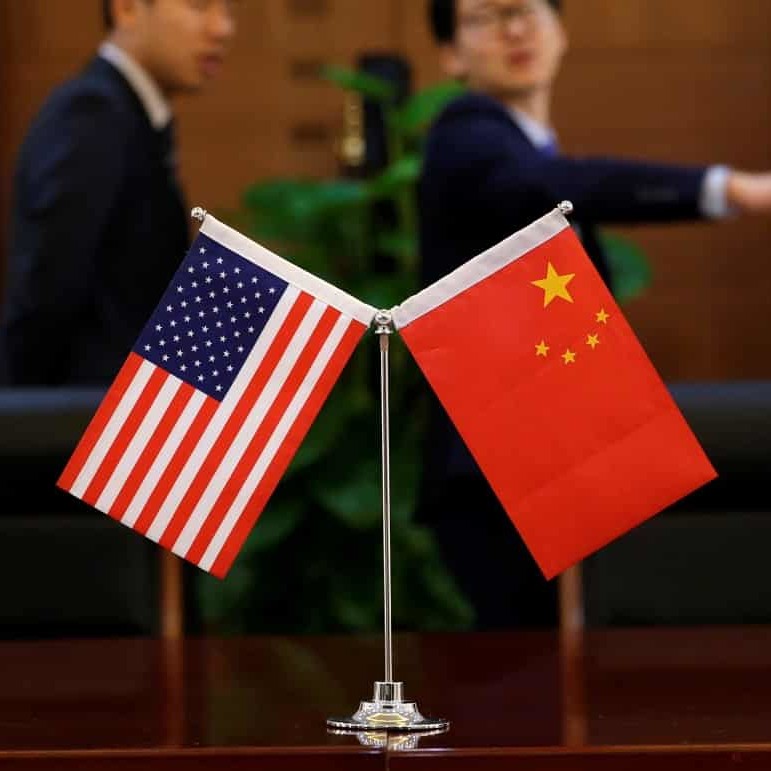«Troppo poco, troppo tardi». Così hanno risposto gli attivisti di Hong Kong all’inversione a U della governatrice Carrie Lam in merito al disegno di legge sull’estradizione. Lam ha ritirato formalmente l’emendamento dopo tre mesi di proteste popolari che nel corso delle settimane sono diventate brutali. Le proteste erano scoppiate in seguito alla presentazione del disegno di legge che avrebbe favorito l’estradizione in Cina dei criminali comuni, ma anche dei dissidenti politici indigesti a Pechino. Via via che trascorrevano le settimane è parso chiaro che l’insoddisfazine di Hong Kong non dipendeva unicamete dalla legge, ma dalle politiche filocinesi di Lam. Ancor di più, era una forma di ribellione più ampia e diretta contro il Governo centrale di Pechino. Mai fino a questo momento era stato così evidente.
Dopo il “ramo d’ulivo” offerto da Lam, le richieste dei manifestanti da cinque sono scese a quattro e gli attivisti non sembrano disposti a fare concessioni. Resta da soddisfare le altre: una commissione di inchiesta davvero indipendente sull’uso eccessivo della forza da parte della polizia, amnistia per tutte le persone arrestate, oltre mille, il diritto a scegliere i propri rappresentanti politici e la fine della retorica cinese che definisce “sommosse” le manifestazioni popolari. Hong Kong combatte contro l’autoritarismo cinese che potrebbe instaurarsi nell’ex possedimento britannico, così almeno spera di fare Pechino che, secondo gli abitanti, da anni persegue una politica volta a cambiare la natura democratica di Hong Kong, anche mettendo mano ai programmi per l’istruzione. Hong Kong è una spina del fianco di Xi Jinping. Non al pari di Taiwan ma proprio per questo la reazione ai piani cinesi da parte dei cittadini del Porto dei profumi, che si pone come modello per quello che Taipei potrebbe essere un giorno, è semplicemente qualcosa che Pechino non può tollerare.
Di certo, il presidente cinese non ha gradito il nervosismo e le violenze di Hong Kong. Ha atteso e ha osservato da lontano, per poi esprimere il supporto a Carrie Lam in una conferenza stampa che non ha precedenti dal 1997, anno del passaggio di Hong Kong alla Cina. In ogni caso, l’unica che si è giocata tutto è stata Carrie Lam, perché se la legge sull’estradizione si fosse rivelata un fallimento, a pagare sarebbe stata solo lei. Ma Lam appena pochi giorni prima del ritiro del provvedimento aveva rivelato in un audio segreto, il cui contenuto è stato diffuso in esclusiva da Reuters, di avere un margine di manovra «molto, molto, molto limitato» e che la gestione della crisi dipendeva tutta la Cina. Queste rivelazioni, espresse da Lam con voce sofferta in una riunione a porte chuse con alcuni uomini d’affari, sono parse quasi un modo per prendere le distanze dalla Cina, un maniera per scrollarsi di dosso ogni responsabilità, nel caso di una risposta più dura da parte di Pechino. Il ritiro formale e definitivo della legge, forse concordato con Pechino, apparirebbe peraltro un tentativo di non rovinare la festa al presidente Xi Jinping. Festa prevista per il primo ottobre, quando verrano celebrati i 70 anni della Repubblica popolare. No, almeno per allora, nessun grattacapo.
Mentre ad Hong Kong si consumavano scontri violenti tra polizia e manifestanti, nel resto della Cina continentale Pechino ha cercato prima di oscurare le notizie sulle dimostrazioni, poi ha condotto una campagna di diffamazione volta a screditare i cittadini di Hong Kong, arrivando anche a definirli terroristi. Puntando in particolare sul fattore dell’ingerenza esterna e attraverso il sabotaggio di strumenti come Telegram, oggetto di attacchi tali da impedirne il funzionamento. Una campagna utile a rafforzare i sentimenti patriottici di attaccamento alla Cina che pare stia funzionando.
Con le truppe di Pechino alle porte di Hong Kong è andato via via crescendo il timore che potesse verificarsi una nuova Tiananamen. Un contingente paramilitare dell’Esercito cinese è arrivato a Shenzhen. È stato il momento in cui gli osservatori occidentali hanno drizzato le antenne. Secondo alcune analisi, il presidente cinese si prepara a una dura repressione delle proteste, qualora l’ardore di Hong Kong non si spenga nel prossimo futuro. L’intervento dell’esercito e l’occupazione militare della città, tuttavia, non sembrano un’alternativa da tenere troppo in considerazione. In primo luogo per l’aspetto legale che impedisce il dispiegamento militare tranne che per ragioni di difesa e solo dietro richiesta del governo locale. Altro motivo: sono passati 30 anni dai fatti di Tiananmen, oggi nascondere un crimine di così vasta portata sarebbe pressoché impossibile. Inoltre, la Cina è in piena guerra commerciale con gli Stati Uniti e una seconda Tiananmen comprometterebbe il ruolo che la Repubblica popolare si è conquistata negli affari globali e le sue ambizioni a essere la prima superpotenza. In questo quadro contano anche i mega progetti della Nuova Via della Seta. L’ultimo elemento da considerare è il progetto di Pechino della Greater Bay area, le cui prospettive di crescita economica dovrebbero attirare il favore della goiventù di Hong Kong. Un piano non nuovo per la Cina – perché i progetti infrastrutturali sono uno strumento utilizzato per l’integrazione anche dello Xinjiang – che punta a inglobare sempre di più Hong Kong nell’economia della Cina continentale, sedando le aspirazioni a una maggiore autonomia politica. Proprio lo Xinjiang e i diritti umani negati spaventano i cittadini di Hong Kong.
Chinese President Xi Jinping poses with Hong Kong’s Chief Executive-elect Carrie Lam ahead of a meeting in Hong Kong, Saturday, July 1, 2017. (Billy H.C. Kwok/Pool Photo via AP)
Erminia Voccia
Giornalista professionista, campana, classe 1986, collabora con Il Mattino di Napoli. Laurea magistrale in Relazioni Internazionali presso l’Università “L’Orientale” di Napoli. Master in giornalismo e giornalismo radiotelevisivo presso Eidos di Roma. Appassionata di Asia.
La crisi della democrazia negli Stati Uniti
14 Lug 2024
Che America è quella che andrà al voto il 5 novembre 2024 per eleggere il suo presidente? Chi vincerà lo scontro tra…
Viktor Orbán, storia di un autorevole autoritario
9 Lug 2024
Era il primo gennaio 2012 quando la nuova, e subito contestata, Costituzione ungherese entrava in vigore. I segnali di…
L’Europa e le vere sfide del nostro tempo
29 Mag 2024
Nel saggio Rompere l'assedio, in uscita il 31 maggio per Paesi Edizioni, Roberto Arditti, giornalista da oltre…
Hi-Tech: i punti deboli della Cina
21 Mag 2024
La sfida tra Stati Uniti e Cina in campo tecnologico mostra una Cina nettamente indebolita nonostante la sua guerra…